DECRETO
MINISTERIALE 9-01-1996
Norme
tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche
Parte 2 - Sezione
II
Calcolo ed esecuzione
4. NORME DI CALCOLO: VERIFICA DI RESISTENZA.
4.0. Generalità
Le strutture di
acciaio realizzate con i materiali previsti al precedente punto 3,
devono essere progettate per i carichi definiti dalle norme in
vigore, secondo i metodi della scienza delle costruzioni e seguendo
il metodo degli stati limite specificato nelle norme tecniche
"Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni
e dei carichi e sovraccarichi", emanate in applicazione dell'art. 1
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Il metodo degli stati limite
viene applicato - considerando le azioni di calcolo e le resistenze
di calcolo previste ai punti 4.0.1. e 4.0.2. - con riferimento o
"allo stato limite elastico della sezione" (punto 4.0.3.1.), oppure,
in alternativa, allo "stato limite di collasso plastico della
struttura" (punto 4.0.3.2.); sono inoltre obbligatorie le verifiche
agli stati limite di esercizio (punto 4.0.4.).
4.0.1 AZIONI DI CALCOLO.
Si adotteranno le
azioni di calcolo e relative combinazioni, indicate al punto 7 delle
premesse.
4.0.2. RESISTENZA DI CALCOLO.
La resistenza
di calcolo fd è definita mediante
l'espressione:
![]()
dove:
fy è il valore dello snervamento
quale risultante dai prospetti 1-II e 2-II e tenendo conto dello
spessore del laminato;![]() è specificato ai successivi punti 4.0.3.1. e
4.0.3.2.
è specificato ai successivi punti 4.0.3.1. e
4.0.3.2.
4.0.3. STATI LIMITE ULTIMI.
4.0.3.1. Stato limite elastico della
sezione.
Si assume che gli effetti delle azioni di
calcolo definite in 4.0.1., prescindendo dai fenomeni di instabilità
(ma comprese le maggiorazioni per effetti dinamici), non comportino
in alcun punto di ogni sezione il superamento della deformazione
unitaria corrispondente al limite elastico del materiale. Si
assumerà ![]() =1,0.
=1,0.
In tal caso è ammesso il calcolo elastico
degli effetti delle azioni di calcolo. Qualora si tenga conto di
effetti dovuti a stati di presollecitazione è obbligatoria anche la
verifica di cui al punto 4.0.3.2. con coefficiente ![]() =0,90 per effetti favorevoli e
=0,90 per effetti favorevoli e ![]() =1,2 per quelli sfavorevoli.
=1,2 per quelli sfavorevoli.
Salvo più
accurate valutazioni la verifica delle unioni potrà essere condotta
convenzionalmente nel modo seguente: per la resistenza di calcolo
delle unioni bullonate si potranno adottare i valori indicati nel
prospetto 7-II; per altre unioni potranno applicarsi le formule ed i
procedimenti indicati in 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. e 4.7.
Si dovrà
anche verificare che siano soddisfatte le verifiche nei confronti
dei fenomeni di instabilità della struttura, degli elementi
strutturali che la compongono e di parti di essi. La resistenza
caratteristica di membrature soggette a fenomeni di instabilità
potrà essere determinata con i metodi indicati al punto
5.
4.0.3.2. Stato limite di collasso plastico della
struttura.
Si assume come stato limite ultimo il
collasso per trasformazione della struttura o di una sua parte in un
meccanismo ammettendo la completa plasticizzazione delle sezioni
coinvolte nella formazione del meccanismo. Si assumerà nei
calcoli![]() =1,12 e si verificherà che in corrispondenza delle azioni
di calcolo definite in 4.0.1. non si raggiunga lo stato limite in
esame.
=1,12 e si verificherà che in corrispondenza delle azioni
di calcolo definite in 4.0.1. non si raggiunga lo stato limite in
esame.
Si dovrà garantire che il meccanismo risultante dai
calcoli possa venir raggiunto sia verificando che nelle zone
plasticizzate le giunzioni abbiano una duttilità sufficiente, sia
premunendosi contro i fenomeni di instabilità della struttura, degli
elementi strutturali che la compongono e di parti di essi.
Il
procedimento qui indicato non è consentito qualora i fenomeni di
fatica divengano determinanti ai fini del calcolo della
struttura.
4.0.4. STATI LIMITE DI ESERCIZIO.
Per gli
stati limite di esercizio si prenderanno in esame le combinazioni
rare, frequenti e quasi permanenti con ![]() =
=![]() =1,0, e applicando ai valori caratteristici delle azioni
variabili adeguati coefficienti riduttivi
=1,0, e applicando ai valori caratteristici delle azioni
variabili adeguati coefficienti riduttivi ![]() indicati al punto 7 della Parte Generale.
indicati al punto 7 della Parte Generale.
4.1. Materiale base.
4.1.1. STATI MONOASSIALI.
4.1.1.1. Resistenza di calcolo
fd a trazione o compressione per acciaio
laminato.
Per le verifiche agli stati limite ultimi di
cui al punto 4.0.3. si assumono, per gli acciai aventi le
caratteristiche meccaniche indicate al punto 2.1.1., i valori della
resistenza di calcolo ¦d riportati nel prospetto
5-II.
PROSPETTO 5-II
|
Materiale |
fd
(N/mm2) |
fd
(N/mm2) |
|
Fe 360 |
235 |
210 |
|
Fe 430 |
275 |
250 |
|
Fe 510 |
355 |
315 |
t=spessore (in mm) | ||
4.1.1.2. Resistenza di calcolo
fd a trazione e compressione per pezzi di
acciaio fuso UNI 3158 (dicembre 1977).
PROSPETTO 6-II
|
MATERIALE |
fd
(N/mm2) |
|
Fe G 400 |
180 |
|
Fe G 450 |
225 |
|
Fe G 520 |
255 |
|
t=spessore (mm) | |
4.1.2. STATI PLURIASSIALI.
Per gli stati
piani, i soli per i quali si possono dare valide indicazioni, si
deve verificare che risulti ![]() essendo nel riferimento generico:
essendo nel riferimento generico:
![]()
e nel riferimento principale:
![]()
in
particolare per ![]() = 0 (per esempio nella sollecitazione di flessione
accompagnata da taglio):
= 0 (per esempio nella sollecitazione di flessione
accompagnata da taglio):
![]()
e nel caso di tensione tangenziale pura:
![]()
4.1.3. COSTANTI ELASTICHE.
Per tutti gli
acciai considerati si assumono i seguenti valori delle costanti
elastiche:
- modulo di elasticità normale E = 206000
N/mm2
- modulo di elasticità tangenziale G = 78400
N/mm2
4.2. Unioni con bulloni.
Le
resistenze di calcolo dei bulloni sono riportate nel prospetto 7-II.
![]() e
e ![]() rappresentano i valori medi delle tensioni nella
sezione.
rappresentano i valori medi delle tensioni nella
sezione.
La tensione di trazione per i bulloni deve essere
valutata mettendo in conto anche gli effetti leva e le eventuali
flessioni parassite. Ove non si proceda alle valutazioni
dell'effetto leva e di eventuali flessioni parassite, le tensioni di
trazione ![]() devono essere incrementate del 25%.
devono essere incrementate del 25%.
PROSPETTO 7-II
|
Stato di tensione | |||||
|
Classe |
ft |
fy |
fk,N |
fd,N |
fd,V |
|
4.6 |
400 |
240 |
240 |
240 |
170 |
|
5.6 |
500 |
300 |
300 |
300 |
212 |
|
6.8 |
600 |
480 |
360 |
360 |
255 |
|
8.8 |
800 |
640 |
560 |
560 |
396 |
|
10.9 |
1000 |
900 |
700 |
700 |
495 |
|
fk,N = è assunto pari al
minore dei due valori fk,N =0.7
ft (fk,N=0.6
f t per viti di classe
6.8) | |||||
|
fd,N = fk,N = resistenza di calcolo a trazione | |||||
|
fd,V =
fk,N / | |||||
Ai fini
del calcolo della ![]() la sezione resistente è quella della vite; ai fini del
calcolo della
la sezione resistente è quella della vite; ai fini del
calcolo della ![]() la sezione resistente è quella della vite o quella totale
del gambo a seconda che il piano di taglio interessi o non interessi
la parte filettata.
la sezione resistente è quella della vite o quella totale
del gambo a seconda che il piano di taglio interessi o non interessi
la parte filettata.
Nel caso di presenza contemporanea di sforzi
normali e di taglio deve risultare:
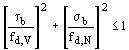
La
pressione sul contorno del foro ![]() , alla proiezione diametrale della superficie
cilindrica del chiodo e del bullone, deve risultare:
, alla proiezione diametrale della superficie
cilindrica del chiodo e del bullone, deve risultare:
![]()
essendo:![]() = a/d e comunque da assumersi non superiore a
2,5;
= a/d e comunque da assumersi non superiore a
2,5;
fd la resistenza di calcolo del
materiale costituente gli elementi del giunto (vedi
4.1.1.1.);
a e d definiti limitati al punto
7.2.4.
I bulloni di ogni classe devono essere convenientemente
serrati.
4.3. Unioni a taglio con chiodi.
Per
i chiodi di cui al punto 2.7., si possono assumere per le resistenze
di calcolo i valori riportati nel prospetto 8-II.
PROSPETTO 8-II
| fd,V N/mm2 | fd,N N/mm2 |
| 180 | 75 |
Di regola
i chiodi non devono essere sollecitati a sforzi di trazione.
Nel
caso di combinazioni di taglio e trazione, si dovrà verificare che
risulti:
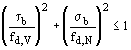
Per la pressione di rifollamento vale quanto indicato per i bulloni.
4.4. Unioni ad attrito con
bulloni.
La forza Ff
trasmissibile per attrito da ciascun bullone per ogni piano di
contatto tra gli elementi da collegare, è espressa dalla
relazione:
Ff =![]()
in cui è
da porre:
vf coefficiente di sicurezza
contro lo slittamento, da assumersi pari a:
1,25 per le verifiche
in corrispondenza degli stati limite di esercizio (sempre
obbligatorie);
1,00 per le verifiche in corrispondenza degli
stati limite ultimi (quando questo tipo di verifica è esplicitamente
richiesto nelle prescrizioni di progetto);![]() coefficiente di attrito da assumersi pari a:
coefficiente di attrito da assumersi pari a:
0,45 per superfici
trattate come indicato al punto 7.10.2.;
0,30 per superfici non
particolarmente trattate, e comunque nelle giunzioni effettuate in
opera;
Nb forza di trazione nel
gambo della vite.
La pressione convenzionale sulle pareti dei
fori non deve superare il valore di 2,5 fd
.
In un giunto per attrito i bulloni ad alta resistenza possono
trasmettere anche una forza assiale di trazione N. In questo
caso, sempreché non concorrano flessioni parassite apprezzabili nel
bullone, il valore della forza ancora trasmissibile dal bullone per
attrito si riduce a:
Ff,red=Ff ![]()
La forza
N nel bullone non può in nessun caso superare il valore 0,8
Nb .
I bulloni di ciascuna classe
debbono in ogni caso essere serrati con coppia tale da provocare una
forza di trazione Nb nel gambo della vite
pari a:
Nb=0,8 fy Ares
essendo Ares l'area della sezione resistente della vite e fy la tensione di snervamento, su vite (prospetto 7-II), valutate secondo UNI EN 20898/1 (dicembre 1991).
4.5. Unioni saldate.
4.5.1. GIUNTI TESTA A TESTA OD A T A COMPLETA
PENETRAZIONE.
Per il calcolo delle tensioni derivanti da
trazioni o compressioni normali all'asse della saldatura o da azioni
di taglio, deve essere considerata come sezione resistente la
sezione longitudinale della saldatura stessa; agli effetti del
calcolo essa avrà lunghezza pari a quella intera della saldatura e
larghezza pari al minore dei due spessori collegati, misurato in
vicinanza della saldatura per i giunti di testa e allo spessore
dell'elemento completamente penetrato nel caso di giunti a T (vedere
figura 1- II).
Per il calcolo delle tensioni derivanti da
trazioni o compressioni parallele all'asse della saldatura, deve
essere considerata come sezione resistente quella del pezzo saldato
ricavata normalmente al predetto asse (cioè quella del materiale
base più il materiale d'apporto).
Per trazioni o compressioni
normali all'asse del cordone la tensione nella saldatura non deve
superare 0,85 fd per giunti testa a testa
di II classe ed fd per gli altri
giunti.
Per sollecitazioni composte deve risultare:
![]()
![]()
![]()
dove:![]() è la tensione di trazione o compressione normale
alla sezione longitudinale della saldatura;
è la tensione di trazione o compressione normale
alla sezione longitudinale della saldatura;![]() la tensione di trazione o compressione parallela
all'asse della saldatura;
la tensione di trazione o compressione parallela
all'asse della saldatura;![]() è la tensione tangenziale nella sezione
longitudinale della saldatura.
è la tensione tangenziale nella sezione
longitudinale della saldatura.
4.5.2. GIUNTI A CORDONI D'ANGOLO.
Si assume
come sezione resistente la sezione di gola del cordone, cui si
attribuisce larghezza pari all'altezza "a" del triangolo
isoscele iscritto nella sezione trasversale del cordone e l'intera
lunghezza "l" del cordone stesso, a meno che questo non abbia
estremità difettose (fig. 2-II).
Della tensione totale agente
sulla sezione di gola, ribaltata su uno dei piani d'attacco, si
considerano le componenti: normale ![]() (trasversale) o tangenziale
(trasversale) o tangenziale ![]() (trasversale) e
(trasversale) e ![]() (parallela).
(parallela).
Per la verifica, i valori assoluti
delle predette componenti dovranno soddisfare le
limitazioni:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
con ovvie
semplificazioni quando due soltanto o una sola delle componenti
siano diverse da zero.
Si ritengono non influenti sul
dimensionamento eventuali tensioni normali ![]() sulla sezione trasversale del cordone (fig.
2-II).
sulla sezione trasversale del cordone (fig.
2-II).
4.6. Unioni per contatto.
È ammesso
l'impiego di unioni per contatto nel caso di membrature
semplicemente compresse, purché, con adeguata lavorazione meccanica,
venga assicurato il combaciamento delle superfici del giunto.
La
tensione di compressione deve risultare minore o uguale a
fd .
In corrispondenza dei giunti ai
piani intermedi o delle piastre di base, le colonne degli edifici
possono essere collegate per contatto. In ogni caso debbono essere
sempre previsti collegamenti chiodati, bullonati o saldati in grado
di assicurare una corretta posizione mutua tra le parti da
collegare. Le unioni per contatto non debbono distare dagli
orizzontamenti di piano più di 1/5 dell'interpiano.
Per le altre
membrature compresse, i collegamenti debbono non solo assicurare una
corretta posizione delle parti da collegare, ma essere anche
dimensionati in modo da poter sopportare il 50% delle azioni di
calcolo.
In ogni caso i collegamenti di cui sopra devono essere
proporzionati in modo da sopportare ogni eventuale azione di
trazione che si determini sovrapponendo agli effetti delle azioni
laterali sulla struttura il 75% degli sforzi di compressione dovuti
ai soli carichi permanenti.
4.7. Apparecchi di appoggio fissi o
scorrevoli.
Tutti gli elementi degli apparecchi di
appoggio, in particolare le piastre, devono essere proporzionati per
gli sforzi, normali, di flessione e taglio, cui sono
sottoposti.
Se l'apparecchio di appoggio deve consentire le
dilatazioni termiche, nel relativo calcolo si assumerà il
coefficiente di dilatazione lineare ![]() .
.
Le parti degli apparecchi di appoggio che trasmettono
pressioni localizzate per contatto saranno eseguite con acciaio fuso
tipo Fe G 520 UNI 3158 (dicembre 1977) o fucinato, oppure mediante
saldatura di elementi laminati di acciaio.
Le pressioni di
contatto, calcolate a mezzo delle formule di Hertz, devono
risultare:
- per contatto lineare: ![]()
- per contatto puntuale: ![]()
Nel caso in cui la localizzazione della
reazione d'appoggio venga ottenuta mediante piastre piane la
pressione media di contatto superficiale deve risultare:
![]()
4.8. Indebolimento delle sezioni.
4.8.1. UNIONI A TAGLIO CON CHIODI O CON
BULLONI.
Per le verifiche di resistenza il calcolo delle
tensioni di trazione si effettua con riferimento all'area netta,
detratta cioè l'area dei fori. L'area netta è quella minima
corrispondente o alla sezione retta o al profilo spezzato.
La
verifica a flessione delle travi sarà effettuata in generale tenendo
conto del momento d'inerzia della sezione con la detrazione degli
eventuali fori. Il calcolo di norma sarà eseguito deducendo dal
momento d'inerzia della sezione lorda il momento d'inerzia delle
aree dei fori rispetto all'asse baricentrico della stessa sezione
lorda.
Per le verifiche di stabilità di cui al successivo punto 5
e per la determinazione di qualunque parametro dipendente dalla
deformabilità, si devono considerare, invece, le sezioni lorde,
senza alcuna detrazione dei fori per i collegamenti.
4.8.2. UNIONI AD ATTRITO.
La detrazione dei
fori dalla sezione deve essere effettuata soltanto se il giunto è
sollecitato a trazione.
La verifica della sezione indebolita si
effettua per un carico pari al 60% di quello trasmesso per attrito
dai bulloni che hanno l'asse nella sezione stessa, oltre al carico
totale trasmesso dai bulloni che precedono.
4.8.3. VERIFICA DEI PROFILATI PARTICOLARI.
I
profilati ad L o a T collegati su un'ala o a U collegati sull'anima,
potranno essere verificati tenendo conto dell'effetto di
ridistribuzione plastica delle tensioni dovute alla eventuale
eccentricità del collegamento. Ciò può essere fatto assumendo come
sezione resistente a trazione una adeguata aliquota della sezione
trasversale netta.
4.9. Norme particolari per elementi inflessi.
Le frecce degli elementi delle strutture
edilizie devono essere contenute quanto è necessario perché non
derivino danni alle opere complementari in genere ed in particolare
alle murature di tamponamento e ai relativi intonaci.
Ai fini del
calcolo si assumono le combinazioni rare per gli stati limite di
servizio; in tali combinazioni i valori delle azioni della neve e
delle pressioni del vento possono essere ridotti al 70%.
Indicativamente la freccia y, in rapporto alla luce l,
deve rispettare almeno i limiti seguenti:
- per le travi di
solai, per il solo sovraccarico, y/l![]() 1/400;
1/400;
- per le travi caricate direttamente da
muri o da pilastri o anche, in assenza di provvedimenti cautelativi
particolari, da tramezzi, per il carico permanente ed il
sovraccarico, y/l![]() 1/500;
1/500;
- per gli arcarecci o gli elementi
inflessi dell'orditura minuta delle coperture, per il carico
permanente ed il sovraccarico, y/l![]() 1/200.
1/200.
Per gli sbalzi i limiti precedenti
possono essere riferiti a una lunghezza l pari a due volte la
lunghezza dello sbalzo stesso.
Ove l'entità delle deformazioni lo
richieda, dovranno essere previste controfrecce adeguate.
Le
frecce teoriche orizzontali degli edifici multipiani alti, dovute
all'azione statica del vento, non devono essere maggiori di 1/500
dell'altezza totale dell'edificio.
Le travi a sostegno di
murature di tamponamento in strutture intelaiate possono calcolarsi
ammettendo che il muro, comportandosi ad arco, si scarichi in parte
direttamente sugli appoggi.
Le travi suddette sono così soggette
a flessione, per effetto del carico della parte di muro sottostante
all'intradosso dell'arco, ed a trazione, per effetto della spinta
dell'arco stesso.
In via di approssimazione si può ritenere che
l'arco abbia freccia pari a 1/2 della luce.
4.10. Fenomeni di fatica.
Si deve
tener conto dei fenomeni di fatica per le strutture o gli elementi
che si prevedono soggetti nel corso della loro vita ad un numero di
cicli di sollecitazione maggiore di 104.
In tale caso
la verifica di resistenza deve essere effettuata negli stati limite
di esercizio, adottando D s ammissibile adeguato; a tale riguardo si
possono adottare le prescrizioni indicate dalle CNR 10011/86
"Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione", oppure altri criteri fondati su
risultati sperimentali di sicura validità.
5. NORME DI CALCOLO: VERIFICA DI STABILITÀ.
5.0. Generalità.
Oltre alle verifiche
di resistenza previste dal precedente punto 4, che in nessun caso
potranno essere omesse, devono essere eseguite le verifiche
necessarie ad accertare la sicurezza della costruzione, o delle
singole membrature, nei confronti di possibili fenomeni di
instabilità.
Le verifiche verranno condotte tenendo conto degli
eventuali effetti dinamici, ma senza considerare le riduzioni delle
tensioni ammissibili ai fenomeni di fatica.
La determinazione
delle tensioni in corrispondenza delle quali possono insorgere
eventuali fenomeni di instabilità, sarà condotta o adottando i
metodi di calcolo indicati dalle norme CNR 10011/86, oppure altri
metodi fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali
chiaramente comprovati.
5.1. Aste compresse.
Si definisce
lunghezza d'inflessione la lunghezza
l0=![]() l da sostituire nel calcolo alla lunghezza
l dell'asta quale risulta nello schema strutturale. Il
coefficiente
l da sostituire nel calcolo alla lunghezza
l dell'asta quale risulta nello schema strutturale. Il
coefficiente ![]() deve essere valutato tenendo conto delle effettive
condizioni di vincolo dell'asta nel piano di flessione
considerato.
deve essere valutato tenendo conto delle effettive
condizioni di vincolo dell'asta nel piano di flessione
considerato.
5.1.1. COEFFICIENTE DI VINCOLO.
Nelle
condizioni di vincolo elementari, per la flessione nel piano
considerato, si assumono i valori seguenti:![]() = 1,0 se i vincoli dell'asta possono
assimilarsi a cerniere;
= 1,0 se i vincoli dell'asta possono
assimilarsi a cerniere;![]() = 0,7 se i vincoli possono assimilarsi ad
incastri;
= 0,7 se i vincoli possono assimilarsi ad
incastri;![]() = 0,8 se un vincolo è assimilabile all'incastro
ed uno alla cerniera;
= 0,8 se un vincolo è assimilabile all'incastro
ed uno alla cerniera;![]() = 2,0 se l'asta è vincolata ad un solo estremo
con incastro perfetto; in tal caso l è la distanza tra la
sezione incastrata e quella di applicazione del carico.
= 2,0 se l'asta è vincolata ad un solo estremo
con incastro perfetto; in tal caso l è la distanza tra la
sezione incastrata e quella di applicazione del carico.
5.1.2. ASTE DI STRUTTURE RETICOLARI.
Per le
aste facenti parti di strutture reticolari si adottano i seguenti
criteri:
- aste di corrente di travi reticolari piane. Per
valutare la lunghezza d'inflessione nel piano della travatura si
pone ![]() =1, per la lunghezza d'inflessione nel piano normale a
quello della travatura, si assume ancora
=1, per la lunghezza d'inflessione nel piano normale a
quello della travatura, si assume ancora ![]() = 1 se esistono alle estremità dell'asta ritegni
trasversali adeguatamente rigidi; per ritegni elasticamente
cedevoli, si dovrà effettuare una verifica apposita;
= 1 se esistono alle estremità dell'asta ritegni
trasversali adeguatamente rigidi; per ritegni elasticamente
cedevoli, si dovrà effettuare una verifica apposita;
- aste di parete. Per la lunghezza d'inflessione nel piano della parete, si assumerà:
![]()
comunque
non minore di 0,8, essendo lred distanza
tra i baricentri delle bullonature, delle chiodature o delle
saldature di attacco alle estremità.
Se, all'incrocio tra un'asta
compressa e una tesa, l'attacco tra le due aste ha una resistenza
non minore di 1/5 di quella dell'attacco di estremità dell'asta
compressa, il punto di incrocio potrà considerarsi impedito di
spostarsi nel piano della parete; in ogni caso però la lunghezza da
considerare non dovrà essere minore di
lo=0,5 l. Per l'inflessione nel
piano normale a quello della parete i coefficienti ![]() vanno determinati mediante metodi di calcolo
che tengono conto delle azioni presenti nella coppia di aste. In
favore di sicurezza si possono assumere quelli indicati al punto
5.1.1.
vanno determinati mediante metodi di calcolo
che tengono conto delle azioni presenti nella coppia di aste. In
favore di sicurezza si possono assumere quelli indicati al punto
5.1.1.
5.1.3. COLONNE.
Per le colonne dei
fabbricati, provviste di ritegni trasversali rigidi in
corrispondenza dei piani, tali cioè da impedire gli spostamenti
orizzontali dei nodi, si assume ![]() =1.
=1.
Per il tronco più basso la lunghezza l
deve essere valutata a partire dalla piastra di
appoggio.
L'eventuale presenza di pannelli a tutt'altezza
sufficientemente rigidi e robusti potrà essere considerata nella
determinazione della lunghezza d'inflessione delle colonne di
fabbricati civili ed industriali, qualora si provveda a rendere
solidali tra loro i pannelli e le colonne.
5.1.4. SNELLEZZA.
Si definisce snellezza di
un'asta prismatica in un suo piano principale di inerzia, il
rapporto ![]() =lo
/i
=lo
/i
dove:
lo è la lunghezza di
inflessione nel piano principale considerato, dipendente, come
specificato nel punto 5.1., dalle modalità di vincolo alle estremità
dell'asta;
i è il raggio d'inerzia della sezione
trasversale, giacente nello stesso piano principale in cui si valuta
lo.
La snellezza non deve superare il valore 200 per le membrature principali e 250 per quelle secondarie; in presenza di azioni dinamiche rilevanti i suddetti valori vengono limitati rispettivamente a 150 e a 200.
5.1.5. VERIFICA.
La verifica di sicurezza di
un'asta si effettuerà nell'ipotesi che la sezione trasversale sia
uniformemente compressa.
Dovrà essere:
![]()
dove:![]() è la tensione critica corrispondente alla forza
Nc, che provoca il collasso elastoplastico
per inflessione dell'asta nel piano che si considera;
è la tensione critica corrispondente alla forza
Nc, che provoca il collasso elastoplastico
per inflessione dell'asta nel piano che si considera;
![]() è la tensione assiale di compressione media
nella sezione della membratura corrispondente al carico assiale
N di calcolo.
è la tensione assiale di compressione media
nella sezione della membratura corrispondente al carico assiale
N di calcolo.
5.1.6. COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE DELLA FORZA
ASSIALE.
In conformità a quanto disposto al punto 5.1.5.,
la verifica di sicurezza di un'asta compressa potrà effettuarsi
nella ipotesi che la sezione trasversale sia compressa da una forza
N maggiorata del coefficiente ![]() .
.
Dovrà cioè essere:
![]()
I
coefficienti ![]() ,
dipendenti dal tipo di sezione oltreché dal tipo di acciaio
dell'asta, si desumono da appositi diagrammi o tabellazioni; si
possono adottare a tale riguardo le indicazioni della norma CNR
10011/86, oppure altre prescrizioni, fondate su ipotesi teoriche e
risultati sperimentali chiaramente comprovati.
,
dipendenti dal tipo di sezione oltreché dal tipo di acciaio
dell'asta, si desumono da appositi diagrammi o tabellazioni; si
possono adottare a tale riguardo le indicazioni della norma CNR
10011/86, oppure altre prescrizioni, fondate su ipotesi teoriche e
risultati sperimentali chiaramente comprovati.
5.1.7. RAPPORTI DI LARGHEZZA-SPESSORE DEGLI ELEMENTI
IN PARETE SOTTILE DELLE ASTE COMPRESSE.
Per evitare
fenomeni locali d'imbozzamento, dovranno essere opportunamente
limitati i rapporti larghezza-spessore degli elementi in parete
sottile di aste compresse, in funzione della forma chiusa o aperta
della sezione trasversale, della presenza o meno di irrigidimenti
lungo i bordi delle pareti e del tipo di acciaio impiegato.
Per
le sezioni aperte dotate di pareti sottili con bordi egualmente o
diversamente irrigiditi, dovrà essere inoltre controllata
l'efficacia degli irrigidimenti in relazione ai rapporti
larghezza-spessore adottati.
5.2. Travi inflesse a parete piena.
5.2.1. STABILITA' ALL'IMBOZZAMENTO DELLE PARTI
COMPRESSE DI TRAVI INFLESSE.
Quando non si proceda ad un
preciso calcolo specifico, le dimensioni delle parti sottili
uniformemente compresse devono soddisfare le limitazioni valide per
analoghe parti di aste compresse, come indicato al punto
5.1.7.
5.2.2. STABILITA' LATERALE DELLE TRAVI INFLESSE
(SICUREZZA ALLO SVERGOLAMENTO).
Per la verifica di una
trave inflessa deve risultare:
![]()
essendo:![]() la massima tensione al lembo compresso,
la massima tensione al lembo compresso,
![]() ,
,
con Mc momento massimo calcolato per la condizione critica di carico, tenuto conto del comportamento elastoplastico della sezione e W modulo di resistenza relativo al lembo compresso.
5.3. Aste pressoinflesse.
Nel caso di
aste soggette ad azioni assiali di compressione N e a momento
flettente M, bisognerà tener conto della riduzione della
capacità portante dell'asta a compressione a causa degli effetti
flettenti. Tale valutazione sarà fatta mediante formule di
interazione basate su metodi di calcolo o sperimentali
comprovati.
Se il momento flettente varia lungo l'asta, la
verifica potrà effettuarsi introducendo nella formula il momento
flettente, costante lungo l'asta, equivalente ai fini della verifica
di stabilità.
5.4. Archi.
Le strutture ad arco
devono essere progettate con appropriati metodi analitici; la
stabilità globale deve essere garantita con un rapporto tra i
carichi corrispondenti alle predette instabilità ed i carichi
corrispondenti alla condizione di calcolo per le verifiche agli
stati limite ultimi non minore di 1,6.
5.5. Telai.
Nelle strutture
intelaiate la stabilità delle singole membrature deve essere
verificata in conformità a quanto indicato nei punti 5.1., 5.2. e
5.3., tenendo ben presenti le condizioni di vincolo e di
sollecitazione.
5.5.1. TELAI A NODI FISSI.
Nei telai in cui
la stabilità laterale è assicurata dal contrasto di controventamenti
adeguati, la lunghezza di inflessione dei piedritti, in mancanza di
un'analisi rigorosa, sarà assunta pari alla loro altezza.
5.5.2. TELAI A NODI SPOSTABILI.
a) Telai
monopiano.
Se la stabilità laterale è affidata unicamente
alla rigidezza flessionale dei piedritti e dei traversi, rigidamente
connessi fra loro, la lunghezza di inflessione delle membrature va
determinata mediante apposito esame. La lunghezza di inflessione dei
ritti sarà assunta comunque non minore della loro altezza qualora
siano incastrati al piede, e al doppio della loro altezza se
incernierati alla base.
b) Telai multipiano.
La
stabilità globale deve essere garantita con un rapporto tra i
carichi corrispondenti alla predetta instabilità ed i carichi
corrispondenti alla condizione di calcolo per le verifiche agli
stati limite ultimi non minore di 1,6.
La stabilità globale può
essere saggiata indirettamente controllando che la struttura sia
capace di sopportare l'azione delle forze orizzontali pari a 1/80
dei carichi permanenti e sovraccarichi supposte agenti
contemporaneamente ai massimi carichi di progetto, per le verifiche
agli stati limite ultimi, vento escluso.
La freccia orizzontale
corrispondente deve essere minore di 1/330 della altezza totale del
telaio.
5.6. Stabilità dell'anima di elementi strutturali a parete piena.
5.6.1. VERIFICA ALL'IMBOZZAMENTO.
I pannelli
d'anima di elementi strutturali a parete piena devono essere
verificati all'imbozzamento e, localmente, in corrispondenza di
eventuali carichi concentrati applicati fra gli irrigidimenti.
In
particolare, nelle verifiche all'imbozzamento, dovrà
essere:
![]()
dove:![]() è la tensione normale critica di confronto
corrispondente alla condizione di carico assegnata;
è la tensione normale critica di confronto
corrispondente alla condizione di carico assegnata;![]() è la tensione normale ideale equivalente
valutata con riferimento alla massima tensione normale di
compressione e ad una tensione tangenziale media.
è la tensione normale ideale equivalente
valutata con riferimento alla massima tensione normale di
compressione e ad una tensione tangenziale media.
Laddove
esistano adeguate riserve di resistenza in fase post- critica, si
potrà tenerne conto aumentando giustificatamente il valore della
tensione normale di confronto ![]() .
.
5.6.2. CONTROLLO DEGLI IRRIGIDIMENTI.
La
verifica di cui al punto 5.6.1. deve essere integrata da un
controllo degli irrigidimenti trasversali e longitudinali dell'anima
al fine di garantire l'efficienza statica dell'insieme.
Gli
irrigidimenti verticali in corrispondenza degli appoggi e dei
carichi concentrati in genere devono essere verificati al carico di
punta per l'intera azione localizzata.
6. VERIFICHE MEDIANTE PROVE SU STRUTTURE CAMPIONE E SU MODELLI.
6.1. Prove su strutture o elementi
campione.
Nel caso che la verifica sia riferita ad
esperienze dirette su struttura campione da effettuare sotto il
controllo di un Laboratorio Ufficiale, su un adeguato numero di
elementi, tale da consentire una convincente elaborazione statistica
dei risultati, e nei quali siano fedelmente riprodotte le condizioni
di carico e di vincolo, il minimo valore del coefficiente di
sicurezza delle azioni di progetto agli stati limite ultimi rispetto
alla resistenza sperimentale a rottura non deve essere inferiore a
1,33, mentre il valore medio del coefficiente di sicurezza non deve
essere inferiore a 1,53. Detti coefficienti devono essere
opportunamente incrementati nel caso di azioni ripetute, a meno che
l'effettiva storia di carico non venga riprodotta nelle prove. Ove
siano da temere fenomeni di instabilità globale e locale, ovvero
rotture senza preavviso, i coefficienti di sicurezza devono essere
opportunamente maggiorati.
6.2. Prove su modelli.
Per strutture
di particolare complessità, le ipotesi a base del calcolo potranno
essere guidate dai risultati di prove su modelli.
7. REGOLE PRATICHE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
7.1. Composizione degli elementi strutturali.
7.1.1. SPESSORI LIMITE.
È vietato l'uso di
profilati con spessore t<4 mm. Una deroga a tale norma,
fino ad uno spessore t = 3 mm, è consentita per opere
sicuramente protette contro la corrosione, quali per esempio tubi
chiusi alle estremità e profilati zincati, od opere non esposte agli
agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano
ovviamente elementi di lamiera grecata e profili sagomati a freddo
in genere per i quali occorre fare riferimento ad altre prescrizioni
costruttive e di calcolo.
7.1.2. IMPIEGO DEI FERRI PIATTI.
L'impiego
di piatti o larghi piatti, in luogo di lamiere, per anime e relativi
coprigiunti delle travi a parete piena, e in genere per gli elementi
in lastra soggetti a stati di tensione biassiali appartenenti a
membrature aventi funzione statica non secondaria, è ammesso
soltanto se i requisiti di accettazione prescritti per il materiale
(in particolare quelli relativi alle prove di piegamento a freddo e
resilienza) siano verificati anche nella direzione normale a quella
di laminazione.
7.1.3. VARIAZIONI DI SEZIONE.
Le eventuali
variazioni di sezione di una stessa membratura devono essere il più
possibile graduali, soprattutto in presenza di fenomeni di fatica.
Di regola sono da evitarsi le pieghe brusche. In ogni caso si dovrà
tener conto degli effetti dell'eccentricità.
Nelle lamiere o
piatti appartenenti a membrature principali e nelle piastre di
attacco le concentrazioni di sforzo in corrispondenza di angoli vivi
rientranti debbono essere evitate mediante raccordi i cui raggi
saranno indicati nei disegni di progetto.
7.1.4. GIUNTI DI TIPO MISTO.
In uno stesso
giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di
forza (ad esempio saldatura e bullonatura o chiodatura), a meno che
uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero
sforzo.
7.2. Unioni chiodate.
7.2.1. CHIODI E FORI NORMALI.
I chiodi da
impiegarsi si suddividono nelle categorie appresso elencate,
ciascuna con l'indicazione della UNI cui devono corrispondere:
-
chiodi a testa tonda stretta, secondo UNI 136 (marzo 1931);
-
chiodi a testa svasata piana, secondo UNI 139 (marzo 1931);
-
chiodi a testa svasata con calotta, secondo UNI 140 (marzo
1931).
I fori devono corrispondere alla UNI 141 (marzo
1931).
7.2.2. DIAMETRI NORMALI.
Di regola si devono
impiegare chiodi dei seguenti diametri nominali:
d = 10,
13, 16, 19, 22, 25 mm;
e, ordinatamente, fori dei
diametri:
d1 = 10,5, 14, 17, 20, 23, 26
mm.
Nei disegni si devono contraddistinguere con opportune
convenzioni i chiodi dei vari diametri. Nei calcoli si assume il
diametro d1, tanto per verifica di
resistenza della chiodatura, quanto per valutare l'indebolimento
degli elementi chiodati.
7.2.3. SCELTA DEI CHIODI IN RELAZIONE AGLI SPESSORI DA
UNIRE.
In relazione allo spessore complessivo t da
chiodare si impiegano:
- chiodi a testa tonda ed a testa svasata
piana, per t/d ![]() 4,5;
4,5;
- chiodi a testa svasata con calotta, per 4,5
< t/d ![]() 6,5.
6,5.
7.2.4. INTERASSE DEI CHIODI E DISTANZA DAI
MARGINI.
In rapporto al diametro d dei chiodi,
ovvero al più piccolo t1 tra gli
spessori collegati dai chiodi, devono essere soddisfatte le
limitazioni seguenti:
- per le file prossime ai bordi:

p/t1 ![]()
![]()
![]() (
(![]() 9 se il margine è irrigidito)
9 se il margine è irrigidito)
dove:
p è la distanza tra centro e centro di chiodi
contigui;
a è la distanza dal centro di un chiodo al
margine degli elementi da collegare ad esso più vicino nella
direzione dello sforzo;
a1 è la distanza
come la precedente a, ma ortogonale alla direzione dello
sforzo;
t1 è il minore degli spessori
degli elementi collegati.
Quando si tratti di opere non esposte
alle intemperie, le ultime due limitazioni possono essere sostituite
dalle seguenti:
![]()
Deroghe eventuali alle prescrizioni di cui al presente punto 7.2.4. debbono essere comprovate da adeguate giustificazioni teoriche e sperimentali.
7.3. Unioni con bulloni normali.
7.3.1. BULLONI.
La lunghezza del tratto non
filettato del gambo del bullone deve essere in generale maggiore di
quella della parti da serrare e si deve sempre far uso di rosette.
E' tollerato tuttavia che non più di mezza spira del filetto rimanga
compresa nel foro. Qualora resti compreso nel foro un tratto
filettato se ne dovrà tenere adeguato conto nelle verifiche di
resistenza.
In presenza di vibrazioni o inversioni di sforzo, si
devono impiegare controdadi oppure rosette elastiche, tali da
impedire l'allentamento del dado. Per bulloni con viti 8.8 e 10.9 è
sufficiente l'adeguato serraggio.
7.3.2. DIAMETRI NORMALI.
Di regola si devono
impiegare bulloni dei seguenti diametri:
d = 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 27 mm.
I fori devono avere diametro uguale a
quello del bullone maggiorato di 1 mm fino al diametro 20 mm e di
1,5 mm oltre il diametro 20 mm, quando è ammissibile un assestamento
sotto carico del giunto.
Quando tale assestamento non è ammesso,
il giuoco complessivo tra diametro del bullone e diametro del foro
non dovrà superare 0,3 mm, ivi comprese le tolleranze.
Nei
disegni si devono contraddistinguere con opportune convenzioni i
bulloni dei vari diametri e devono essere precisati i giuochi
foro-bullone.
7.3.3. INTERASSE DEI BULLONI E DISTANZA DAI
MARGINI.
Vale quanto specificato al punto
7.2.4.
7.4. Unioni ad attrito.
7.4.1. BULLONI.
Nelle unioni ad attrito si
impiegano bulloni ad alta resistenza di cui al punto 2.6. Il gambo
può essere filettato per tutta la lunghezza.
Le rosette, disposte
una sotto il dado e una sotto la testa, devono avere uno smusso a
45° in un orlo interno ed identico smusso sul corrispondente orlo
esterno. Nel montaggio lo smusso deve essere rivolto verso la testa
della vite o verso il dado. I bulloni, i dadi e le rosette devono
portare, in rilievo impresso, il marchio di fabbrica e la
classificazione secondo la citata UNI 3740.
7.4.2. DIAMETRI NORMALI.
Di regola si devono
impiegare bulloni dei seguenti diametri:
d = 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 27 mm
e fori di diametro pari a quello del
bullone maggiorato di 1,5 mm fino al diametro 24 mm e di 2 mm per il
diametro 27 mm. Nei disegni devono essere distinti con opportune
convenzioni i bulloni dei vari diametri.
7.4.3. INTERASSE DEI BULLONI E DISTANZA DAI
MARGINI.
Vale quanto specificato al punto
7.2.4.
7.5. Unioni saldate.
A tutti gli
elementi strutturali saldati devono essere applicate le prescrizioni
di cui al punto 7.1.3.
Per gli attacchi d'estremità di aste
sollecitate da forza normale, realizzati soltanto con cordoni
d'angolo paralleli all'asse di sollecitazione, la lunghezza minima
dei cordoni stessi deve essere pari a 15 volte lo
spessore.
L'impiego di saldature entro fori o intagli deve essere
considerato eccezionale: qualora detti fori o intagli debbano essere
usati, il loro contorno non dovrà presentare punti angolosi, né
raggi di curvatura minori di metà della dimensione minima
dell'intaglio.
I giunti testa a testa di maggior importanza
appartenenti a membrature tese esposte a temperature minori di 0°C
devono essere previsti con saldatura di I classe (punto
2.4.3.).
La saldatura a tratti non è ammessa che per cordoni
d'angolo.
Nei giunti a croce o a T a completa penetrazione dovrà
essere previsto un graduale allargamento della saldatura (vedere
figura 3- II), la cui larghezza dovrà essere almeno pari a 1,3 volte
lo spessore t in corrispondenza della lamiera su cui viene a
intestarsi.
7.6. Travi a parete piena e reticolari.
7.6.1. TRAVI CHIODATE.
Nel proporzionamento
delle chiodature che uniscono all'anima i cantonali del corrente
caricato, si deve tener conto del contributo di sollecitazione di
eventuali carichi direttamente applicati al corrente stesso. Se tali
carichi sono concentrati ed il corrente è sprovvisto di piattabande,
si provvederà a diffonderli con piastra di ripartizione.
Le
interruzioni degli elementi costituenti le travi devono essere
convenientemente distanziate e singolarmente provviste di
coprigiunto. La coincidenza trasversale di più interruzioni non è
ammessa neanche per coprigiunto adeguato alla sezione interrotta,
eccettuato il caso di giunti di montaggio. I coprigiunti destinati a
ricostituire l'intera sezione dell'anima devono estendersi
all'intera altezza di essa.
Nelle travi con pacchetti di
piattabande distribuite con il criterio di ottenere l'uniforme
resistenza a flessione, ciascuna piattabanda deve essere attaccata
al pacchetto esternamente alla zona dove ne è necessario il
contributo; il prolungamento di ogni piattabanda oltre la sezione in
cui il momento flettente massimo eguaglia quello resistente, deve
essere sufficiente per consentire la disposizione di almeno due file
di chiodi, la prima delle quali può essere disposta in
corrispondenza della sezione suddetta.
7.6.2. TRAVI SALDATE.
Quando le piattabande
sono più di una per ciascun corrente si potranno unire tra loro con
cordoni d'angolo laterali lungo i bordi, purché abbiano larghezza
non maggiore di 30 volte lo spessore.
L'interruzione di ciascuna
piattabanda deve avvenire esternamente alla zona dove ne è
necessario il contributo, prolungandosi per un tratto pari almeno
alla metà della propria larghezza. In corrispondenza della sezione
terminale di ogni singolo tronco di piattabanda si deve eseguire un
cordone d'angolo di chiusura che abbia altezza di gola pari almeno
alla metà dello spessore della piattabanda stessa e sezione
dissimmetrica col lato più lungo nella direzione della piattabanda.
Inoltre, in presenza di fenomeni di fatica, la piattabanda deve
essere raccordata al cordone con opportuna rastremazione.
7.6.3. NERVATURE DELL'ANIMA.
Le nervature di
irrigidimento dell'anima in corrispondenza degli appoggi della trave
o delle sezioni in cui sono applicati carichi concentrati devono
essere, di regola, disposte simmetricamente rispetto all'anima e
verificate a carico di punta per l'intera azione
localizzata.
Potrà a tali effetti considerarsi collaborante con
l'irrigidimento una porzione d'anima di larghezza non superiore a 12
volte lo spessore dell'anima, da entrambe le parti adiacenti alle
nervature stesse.
Per la lunghezza d'inflessione dovrà assumersi
un valore commisurato alle effettive condizioni di vincolo
dell'irrigidimento ed in ogni caso non inferiore ai 3/4 dell'altezza
dell'anima.
I rapporti larghezza-spessore delle nervature di
irrigidimento dell'anima devono soddisfare le limitazioni previste
al punto 5.1.7.
Le nervature di irrigidimento di travi composte
saldate devono essere collegate all'anima mediante cordoni di
saldatura sottili e, di regola, continui.
Nel caso si adottino
cordoni discontinui, la lunghezza dei tratti non saldati dovrà
essere inferiore a 12 volte lo spessore dell'anima, e, in ogni caso,
a 25 cm; inoltre nelle travi soggette a fatica si verificherà che la
tensione longitudinale nell'anima non superi quella ammissibile a
fatica per le disposizioni corrispondenti.
7.6.4. TRAVI RETICOLARI.
Gli assi
baricentrici delle aste devono di regola coincidere con gli assi
dello schema reticolare; tale avvertenza è particolarmente
importante per le strutture sollecitate a fatica. La coincidenza
predetta per le aste di strutture chiodate o bullonate costituite da
cantonali può essere osservata per gli assi di chiodatura e
bullonatura anziché per gli assi baricentrici.
Il baricentro
della sezione resistente del collegamento ai nodi deve cadere, di
regola, sull'asse geometrico dell'asta. Ove tale condizione non sia
conseguibile, dovrà essere considerato, nel calcolo del
collegamento, il momento dovuto all'eccentricità tra baricentro del
collegamento e asse baricentrico dell'asta.
Nei correnti a
sezione variabile gli elementi, che via via si richiedono in aumento
della sezione resistente, devono avere lunghezza tale da essere
pienamente efficienti là ove ne è necessario il
contributo.
7.7. Piastre od apparecchi di appoggio.
7.7.1. BASI DI COLONNE.
Le piastre di
appoggio e le relative eventuali costolature devono essere
proporzionate in modo da assicurare una ripartizione
approssimativamente lineare della pressione sul cuscinetto
sottostante.
I bulloni di ancoraggio devono essere collocati a
conveniente distanza dalle superfici che limitano lateralmente la
fondazione. La lunghezza degli ancoraggi è quella prescritta al
punto 5.3.3. della Parte 1ª, quando non si faccia ricorso a traverse
d'ancoraggio o dispositivi analoghi.
7.7.2. APPOGGI METALLICI (FISSI E
SCORREVOLI).
Di regola, per gli appoggi scorrevoli, non
sono da impiegare più di due rulli o segmenti di rullo; se i rulli
sono due occorrerà sovrapporre ad essi un bilanciere che assicuri
l'equipartizione del carico. Il movimento di traslazione dei rulli
deve essere guidato in modo opportuno, dispositivi di arresto devono
essere previsti dove il caso lo richieda. Le parti degli apparecchi
che trasmettono pressioni per contatto possono essere di acciaio
fuso, oppure ottenute per saldatura di laminati di acciaio. Le
superfici di contatto devono essere lavorate con macchina
utensile.
7.7.3. APPOGGI DI GOMMA.
Per questo tipo di
appoggi valgono le istruzioni di cui alla norma CNR 10018/87
(Bollettino Ufficiale C.N.R. - XXVI - n. 161 - 1992).
7.8. Marchiatura dei materiali.
I
materiali debbono essere identificabili mediante apposito
contrassegno o marchiatura, specie per quanto riguarda il tipo di
acciaio impiegato.
7.9. Lavorazioni.
Nelle lavorazioni
debbono essere osservate tutte le prescrizioni indicate nel
progetto.
7.10. Modalità esecutive per le unioni.
7.10.1. UNIONI CHIODATE.
Le teste ottenute
con la ribaditura devono risultare ben centrate sul fusto, ben
nutrite alle loro basi, prive di scepolature e ben combacianti con
la superficie dei pezzi. Dovranno poi essere liberate dalle bavature
mediante scalpello curvo, senza intaccare i ferri chiodati.
Le
teste di materiale diverso dall'acciaio Fe 360 ed Fe 430 UNI 7356
(dicembre 1974) porteranno in rilievo in sommità, sopra una zona
piana, un marchio caratterizzante la qualità del materiale.
Il
controstampo dovrà essere piazzato in modo da lasciare sussistere
detto marchio dopo la ribaditura.
7.10.2. UNIONI AD ATTRITO.
Le superfici di
contatto al montaggio si devono presentare pulite, prive cioè di
olio, vernice, scaglie di laminazione, macchie di grasso.
La
pulitura deve, di norma, essere eseguita con sabbiatura al metallo
bianco; è ammessa la semplice pulizia meccanica delle superfici a
contatto per giunzioni montate in opera, purché vengano
completamente eliminati tutti i prodotti della corrosione e tutte le
impurità della superficie metallica. Le giunzioni calcolate con ![]() =0,45 debbono comunque essere sabbiate al
metallo bianco.
=0,45 debbono comunque essere sabbiate al
metallo bianco.
I bulloni, i dadi e le rosette dovranno
corrispondere a quanto prescritto al punto 7.4.1.
Nei giunti
flangiati dovranno essere particolarmente curati la planarità ed il
parallelismo delle superfici di contatto.
Per il serraggio dei
bulloni si devono usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza
meccanismo limitatore della coppia applicata, o chiavi pneumatiche
con limitatore della coppia applicata; tutte peraltro devono essere
tali da garantire una precisione non minore di![]() 5%.
5%.
Il valore della coppia di serraggio, da applicare
sul dado o sulla testa del bullone, deve essere quella indicata nel
punto 4.4.
Per verificare l'efficienza dei giunti serrati, il
controllo della coppia torcente applicata può essere effettuato in
uno dei seguenti modi:
a) si misura con chiave
dinamometrica la coppia richiesta per far ruotare ulteriormente di
10° il dado;
b) dopo aver marcato dado e bullone per
identificare la loro posizione relativa, il dado deve essere prima
allentato con una rotazione almeno pari a 60° e poi riserrato,
controllando se l'applicazione della coppia prescritta riporta il
dado nella posizione originale.
Se in un giunto anche un solo
bullone non risponde alle prescrizioni circa il serraggio, tutti i
bulloni del giunto devono essere controllati.
7.10.3. UNIONI SALDATE.
Sia in officina sia
in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti
devono essere eseguite da saldatori che abbiano superato, per la
relativa qualifica, le prove richieste dalla UNI 4634 (dicembre
1960).
Per le costruzioni tubolari si farà riferimento alla UNI
4633 (dicembre 1960) per i giunti di testa.
Le saldature da
effettuare con altri procedimenti devono essere eseguite da operai
sufficientemente addestrati all'uso delle apparecchiature relative
ed al rispetto delle condizioni operative stabilite in sede di
qualifica del procedimento.
I lembi, al momento della saldatura,
devono essere regolari, lisci ed esenti da incrostazioni, ruggine,
scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità.
Il
disallineamento dei lembi deve essere non maggiore di 1/8 dello
spessore con un massimo di 1,5 mm; nel caso di saldatura manuale
ripresa al vertice, si potrà tollerare un disallineamento di entità
doppia.
Nei giunti di testa ed in quelli a T a completa
penetrazione effettuati con saldatura manuale, il vertice della
saldatura deve essere sempre asportato, per la profondità richiesta
per raggiungere il metallo perfettamente sano, a mezzo di
scalpellatura, smerigliatura, od altro adeguato sistema, prima di
effettuare la seconda saldatura (nel caso di saldature effettuate
dai due lati) o la ripresa.
Qualora ciò non sia assolutamente
possibile, si deve fare ricorso alla preparazione a V con piatto di
sostegno che è, peraltro, sconsigliata nel caso di strutture
sollecitate a fatica od alla saldatura effettuata da saldatori
speciali secondo la citata UNI 4634 o, nel caso di strutture
tubolari, di classe TT secondo la citata UNI 4633.
7.10.4. UNIONI PER CONTATTO.
Le superfici di
contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali all'asse
delle membrature collegate.
Le membrature senza flange di
estremità devono avere le superfici di contatto segate o, se
occorre, lavorate con la piallatrice, la fresatrice o la
molatrice.
Per le membrature munite di flange di estremità si
dovranno distinguere i seguenti casi:
a) per flange di
spessore inferiore o uguale a 50 mm è sufficiente la spianatura alla
pressa o con sistema equivalente;
b) per flange di
spessore compreso tra i 50 ed i 100 mm, quando non sia possibile una
accurata spianatura alla pressa, è necessario procedere alla
piallatura o alla fresatura delle superfici di
appoggio;
c) per flange di spessore maggiore di 100 mm le
superfici di contatto devono sempre essere lavorate alla pialla o
alla fresa.
Nel caso particolare delle piastre di base delle
colonne si distingueranno i due casi seguenti:
a) per basi
senza livellamento con malta occorre, sia per la piastra della
colonna che per l'eventuale contropiastra di fondazione, un accurato
spianamento alla pressa e preferibilmente la piallatura o la
fresatura;
b) per basi livellate con malta non occorre
lavorazione particolare delle piastre di base.
7.10.5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI.
Quando le
superfici comprendenti lo spessore da bullonare per una giunzione di
forza non abbiano giacitura ortogonale agli assi dei fori, i bulloni
devono essere piazzati con interposte rosette cuneiformi, tali da
garantire un assetto corretto della testa e del dado e da consentire
un serraggio normale.
7.11. Verniciatura e zincatura.
Gli
elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata
resistenza alla corrosione, dovranno essere idoneamente protetti
tenendo conto del tipo di acciaio, della sua posizione nella
struttura e dell'ambiente nel quale è collocato.
Devono essere
particolarmente protetti gli elementi dei giunti ad attrito, in modo
da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del giunto.
Il
progettista prescriverà il tipo e le modalità di applicazione della
protezione, che potrà essere di pitturazione o di zincatura a
caldo.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di
conglomerato cementizio non dovranno essere pitturati: potranno
essere invece zincati a caldo.
7.12. Appoggio delle piastre di
base.
È necessario curare che la piastra di base degli
apparecchi di appoggio delle colonne appoggi per tutta la sua
superficie sulla sottostruttura attraverso un letto di
malta.
Indice D.M. 9-01-1996 - Torna all'area consultazione